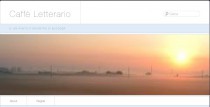Foto Flickr: https://flic.kr/p/pxGPBG
Il 28 Aprile alle 22 il racconto Janine apparso su Caffè Letterario è diventato il testo base della puntata di Mess is more il mio programma settimanale su Libertalia Radio.
La puntata andrà in replica domenica 30 Aprile sempre alle 22.
La playlist Spotify della trasmissione è questa:
La vide. Come ogni mattina d’altronde. Se la trovò davanti con quella stupida espressione assonnata che le dava anche un po’ sui nervi.
«L’ha visto?»
«Cosa?»
Fece un gesto di stizza, «se mi chiede cosa non ha visto nulla. O non ha voluto vedere nulla.»
Anche quella fece un gesto di disappunto, «e perché non avrei voluto, di grazia?»
La ignorò perché non aveva voglia di discutere.
«Comunque non l’ha visto.»
«Ma chi era?», domandò con aria interessata.
«Bisognerebbe chiedersi, cosa. Cosa era?»
«Ahm, ok», fece, «cosa era?»
«Un muoversi, lento. Poi veloce. Uno scivolare ecco.» La osservò, «ha presente lo scivolare? Su quel versante.» Indicò un punto, con tutta evidenza lontano.
«Ma uno scivolare di cosa?»
«Di cosa o di chi?», domandò perplessa.
«Santo cielo», sbuffò, «me lo ha detto lei di chiedere cosa e non chi.»
«Quando?»
«Quando? Ma giusto ora!» urlava quasi, poi però torno di colpo calma. Si guardò intorno, «è una bella giornata oggi.»
Guardò fuori dalla finestra, «e sì, sembra proprio un bella mattina.»
«Potremo andare in giro un po’, arrivare sino alla spiaggia.»
Sorrise; per un attimo sorrise come rallegrata dalla proposta. Compiaciuta. Poi si riebbe con una smorfia, «ma come le viene in mente?»
«Ha già un impegno?»
«Ma come pensa che si possa andare in giro insieme. Vuole che mi porti appresso questo affare?» con un gesto indicò tutto intorno.
«Non si può?»
«Penserebbero tutti che siamo pazze.»
«E non lo siamo?»
«Che io sappia no.»
«Bisognerebbe informarsi. Se lo fossimo allora potremmo anche fare una passeggiata insieme. Un’ora d’aria è concessa financo ai pazzi.»
«Lei conosce qualcuno a cui chiedere? Di noi due di sicuro quella meno sana di mente è lei. Mi scusi eh, ma è evidente.»
Quella lì annuì sconsolata, «è da un po’ che lo penso anche io, ma dovrei almeno fare una visita. Degli esami.»
«E perché non lo fa? Magari agendo per tempo, con una buona cura. Chissà.»
«Oh bella questa. Ma se nemmeno vuole fare una passeggiata come pensa che potrei andare a consulto. E da sola.»
«Pare che ogni cosa adesso sia colpa mia. Ogni volta colpa mia», disse scoppiando a singhiozzare.
Si fermò perplessa. Forse aveva esagerato e sì, si sentiva un po’ in colpa.
«Via, non faccia così, una soluzione la si troverà. Vedrà che si risolve. Potrebbe parlare con sua figlia. Dovrebbe aiutarla di più sua figlia. La vedo poco presente.»
La guardò con aria stupita. «Mia figlia? Ma, che io ricordi non mi sembra di avere figli. Avessi partorito dovrei ricordarlo no?»
«E magari era un cesareo e l’hanno assonnata. Oppure, sì ecco, possibile che l’abbia adottata?»
«Chi?»
«Sua figlia dico. Che sia adottata?»
«Ma che dice io non ho figli.»
«Davvero? Ma allora cambia tutto.»
«Che cambia?»
«Tutto. E si vede che ci devo parlare io.»
«Con chi?»
«Con sua figlia, mica lo può fare lei che non la ricorda?»
Sorrise grata.
«Davvero lo farebbe per me?»
«Ma certo, se non ci aiutiamo tra di noi.»
Rimasero in silenzio come aspettando qualcosa, come se mancasse qualcosa. Poi quella si decise a parlare.
«E però!»
«Cosa?»
«E però come faccio a riconoscerla?»
«Chi?»
«Sua figlia. Io non l’ho mai vista. Le somiglia almeno?»
«Non saprei? Neanche io l’ho mai vista.»
«E questo è un problema, perché se né io né lei l’abbiamo mai vista come si fa a trovarla e parlarci?»
«E no, non è facile. Così è come se non esistesse. Che poi è quello che credevo fino a poco fa.»
«E poi che è successo che ha cambiato idea?»
«Che lei ha deciso di parlaci.»
Tornò il silenzio.
La ragazza scostò appena la porta e guardò dentro. La situazione le sembrò tranquilla e avrebbe avuto il tempo di preparare le ultime cose per la colazione. Percorse il piccolo disimpegno e guadagnò la cucina. Tra mezz’ora la figlia sarebbe arrivata come ogni giorno ed era bene che trovasse la madre con il tavolino apparecchiato. Prese dallo scaffale due tazze colorate e le sistemò una per ogni vassoglietto di legno chiaro. In un piattino mise i biscotti al burro e nelle ciotoline bianche un paio di cucchiaini di marmellata di arance. Guardò il tutto per controllare che non mancasse nulla. Sistemò in ordine ogni cosa sul carrello e si diresse nuovamente verso la camera della signora. Alle pareti le foto di scena la ritraevano insieme ai tanti amici che allora le stavano intorno.
La ragazza pensò che doveva essere stato un mondo strano quello. Ognuno di loro le ricordava qualcosa, un ritaglio di giornale che sua madre collezionava nella scatola di latta rossa. Un servizio in TV la sera, quando il padre stanco si piazzava sul divano del piccolo soggiorno.
Bussò delicatamente e aprì la porta. La signora stava ancora davanti alla toletta e nel vederla entrare interruppe bruscamente la conversazione.
«La colazione signora. Ho portato anche qualcosa per sua figlia che tra poco arriverà di sicuro.»
Aveva un bel sorriso la signora e senza aggiungere nulla la ringraziò con un piccolo inchino.
«Che carina», le disse quella.
«Sì, è davvero un amore», rispose la signora guardando la ragazza disporre tutto sul tavolino vicino la finestra.
«Ma quindi lei sembra conoscere sua figlia.»
«Non credo, vive qui con me. A dir la verità non saprei dire come mai, ma non mi pare gentile chiederle.»
«No, sarebbe scortese. Magari deve essere stato in quel giorno di pioggia.»
«Quale?»
«Ma qualche mese fa, vedevo scendere il diluvio dietro la finestra e se si ricorda si è allagato tutto lo scantinato.»
«Oh certo, adesso ricordo. Dovettero venire i pompieri a cacciar fuori tutta quell’acqua. Ma cosa c’entra con la ragazza?»
«Dico, sarà stata fuori quelgiono lì e la pioggia l’avrà colta di sorpresa. Si sarà rifugiata in casa e poi si è trovata bene ed è rimasta.»
«Già, non vedo altra spiegazione. Ed è scortese chiederle di andarsene.»
«Ma certo. E poi di tutta questa casa che se ne farebbe da sola?»
«Prepara la colazione. È tanto carina.»
«Tanto carina.»
La ragazza con un sorriso si chiuse la porta dietro e si avviò verso l’ingresso. Dovevano aver suonato perché aveva aperto la porta di ingresso e in piedi attendeva qualcuno, scrutando i grandi quadri astratti che pendevano dalle pareti.
La donna comparve sull’uscio.
«Buongiorno Maria, come va stamane?»
«Come sempre, signora.»
«Sempre in amabile compagnia?»
«Credo di sì, stava conversando quando le ho portato la colazione.»
La donna sospirò appena, poggiando il paltò chiaro sulla poltroncina di mogano.
Percorsero insieme la galleria di vecchie memorie che anticipava la stanza della signora. Locandine ingiallite di vecchi teatri si susseguivano tra foto di premiazioni e interviste. La donna ogni volta non poteva non notare in quegli scatti il vertiginoso décolleté, che confrontava con il suo misero equipaggiamento. Neanche quello aveva preso dalla madre, schiva e affezionata ai suoi studi giuridici, nessuna smania artistica e di protagonismo. Lontana da riflettori e palcoscenici.
Ruotò con cautela la maniglia e osservò per un attimo la madre dialogare, anche con una certa foga, con la sua ospite. Si fermò un secondo a riflettere su quella definizione. Ospite alla fine era l’unico termine corretto, visto che quella figura albergava in quella stanza da mesi, giorno e notte, tenendole compagnia.
«Che bella sorpresa», le disse appena la notò entrare nella stanza.
«Vede quante amiche che la vengono a trovare?» sottolineò quella.
«E già, devo aver lasciato un buon ricordo. Ma prego signora si accomodi, stavo proprio per bere il mio caffè. Vuole farmi compagnia?»
La donna rispose che sì, avrebbe davvero gradito e prese posto sulla sedia che la ragazza aveva spostato vicino al tavolino. Riflessa allo specchio osservava il viso ormai scavato della madre. Conservava un tratto malizioso che gli anni e gli acciacchi non avevano oscurato.
«Adesso mi scusi, ma devo dedicare del tempo alla mia amica che è venuta a trovarmi.»
«Certo, capisco», disse quella, «ci rivediamo più tardi comunque. Anzi chieda a lei se ci può dare notizie di sua figlia. Magari la conosce.»
«Proverò, ma lo ritengo poco probabile. A più tardi.»
Poi rivolgendosi nuovamente alla donna le fece un grande sorriso.
«Bene. Ora sono tutta per lei», e come se si fosse di colpo ricordata di qualcosa, «ma che sbadata. Non vi ho nemmeno presentate.»
Nel dirlo si rivolse ancora una volta verso lo specchio dove incrociò gli occhi riflessi della figlia. E quelli sì quelli erano i suoi, il grigio verde chiaro che aveva ammaliato schiere di umonini in gioventù.
«In realtà non ricordo adesso come si chiama la signora che c’era prima. Stava qui, giusto dove ora sta quello specchio. Deve avercelo spostato la ragazza. Ha visto che era andata via e lo deve avere spostato.»
Poi rivolta alla donna con aria mortificata, «non ricordo più quasi nulla, neppure più il mio nome. Non è che per caso lei lo conosce?»
La donna increspò le labbra in un sorriso stanco, «Janine, mamma. Janine.»